
Continua senza sosta a colpi di vaccino, ma non solo, la battaglia contro il coronavirus. Da due anni il SARS-CoV-2 se da un lato mette a dura prova la nostra salute, anche psicologica, dall’altro ha impresso uno slancio enorme alle ricerche scientifiche e alla collaborazione tra professionisti sanitari di diversa specializzazione che stanno unendo le forze per combattere il contagio. Dagli studi in corso e tra i ricercatori si sta, infatti, sempre di più verificando che la strategia difensiva per essere davvero efficace dovrebbe puntare all’associazione di un complesso di armi di diverso tipo.
«Siamo oramai a due anni dall’inizio della pandemia Covid-19, che ha lasciato sul campo solo in Italia oltre 130mila morti e tanti strascichi dolorosi», osserva Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA). «Di certo tanti passi in avanti sono stati fatti con la vaccinazione di massa e i dati di ricoveri e terapie intensive ci dimostrano che aver superato l’80% di copertura con le prime due dosi ha fatto la differenza. Tuttavia, proprio perché stiamo varcando la soglia dei 24 mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria, il mondo scientifico ha compiuto indiscutibili progressi sia nell’inquadramento diagnostico che nella cura e prevenzione di questa nuova infezione da coronavirus, che ci ha trovato impreparati e senza difese come gli indios d’America nei confronti delle malattie sconosciute dei colonizzatori europei. Se dopo meno di un anno avevamo già a disposizione gli innovativi vaccini a RNA messaggero, oggi possiamo contare su anticorpi monoclonali per l’immunizzazione passiva (una sorta di antitetanica post-contatto a rischio), utili per coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi, ma anche nuovi farmaci antivirali appositamente sviluppati.
A questi si sommano le conoscenze e le evidenze prodotte sulle terapie di supporto (come i cortisonici e gli anticoagulanti) piuttosto che sui farmaci sintomatici, ma anche sull’uso di trattamenti di supporto come la lattoferrina e altre molecole già a disposizione dei medici. Insomma, se con il SARS-CoV-2 dovremo imparare a convivere così come abbiamo fatto con l’influenza – che causava 24mila decessi l’anno solo in Italia senza generare bollettini di guerra quotidiani – sarà bene puntare su tutto l’armamentario medico a nostra disposizione, che include i vaccini e per fortuna molto altro: c’è persino chi vorrebbe riprendere gli studi sul plasma iper-immune su cui è calato il sipario dopo l’improvvisa morte dell’ideatore. Ogni battaglia si combatte, infatti, con tutte le frecce che si hanno al proprio arco, specialmente se si ha a che fare con virus capaci di frequenti mutazioni e in presenza di preparati vaccinali che non garantiscono piena immunità ma solo protezione dalle forme più gravi.
 Ci auguriamo che il nostro Paese sia in grado di ottimizzare anche gli aspetti più critici dell’organizzazione sanitaria emersi in questi due anni di emergenza Covid: dalla frantumazione e disuguaglianze sanitarie prodotte dalla regionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale alla mancata incorporazione nel sistema della medicina generale e pediatria di famiglia, fino al declassamento della medicina preventiva territoriale e all’assottigliamento del numero di operatori e posti letto ospedalieri che ha reso difficile fronteggiare la pandemia. Anche su queste frecce dobbiamo poter contare nella lotta al Covid».
Ci auguriamo che il nostro Paese sia in grado di ottimizzare anche gli aspetti più critici dell’organizzazione sanitaria emersi in questi due anni di emergenza Covid: dalla frantumazione e disuguaglianze sanitarie prodotte dalla regionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale alla mancata incorporazione nel sistema della medicina generale e pediatria di famiglia, fino al declassamento della medicina preventiva territoriale e all’assottigliamento del numero di operatori e posti letto ospedalieri che ha reso difficile fronteggiare la pandemia. Anche su queste frecce dobbiamo poter contare nella lotta al Covid».
In questo articolo
Meno ospedalizzazione con gli anticorpi monoclonali
 In tema di ottimizzazione dei posti letto disponibili assume grande rilevanza la possibilità, già autorizzata nel nostro Paese, di ricorrere alla somministrazione di anticorpi monoclonali antivirali o ad attività neutralizzante, come si definiscono in termini tecnici. Precisa in merito Ivan Gentile, professore ordinario di malattie infettive presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, direttore dell’unità operativa complessa di malattie infettive dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, e membro del Comitato Scientifico SIMA: «Si è visto che l’impiego degli anticorpi monoclonali antivirali arriva a ridurre anche del 70% l’ospedalizzazione causata da decorso grave della malattia. Il legislatore a oggi permette che siano somministrati in ospedale entro al massimo dieci giorni dal contagio con iniezione endovenosa a persone cosiddette fragili, perché con fattori di rischio che portano a prevedere un’evoluzione severa dei sintomi, per esempio individui obesi, affetti da diabete, cardiopatie, insufficienza renale, forme tumorali e over 65 anni…
In tema di ottimizzazione dei posti letto disponibili assume grande rilevanza la possibilità, già autorizzata nel nostro Paese, di ricorrere alla somministrazione di anticorpi monoclonali antivirali o ad attività neutralizzante, come si definiscono in termini tecnici. Precisa in merito Ivan Gentile, professore ordinario di malattie infettive presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, direttore dell’unità operativa complessa di malattie infettive dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, e membro del Comitato Scientifico SIMA: «Si è visto che l’impiego degli anticorpi monoclonali antivirali arriva a ridurre anche del 70% l’ospedalizzazione causata da decorso grave della malattia. Il legislatore a oggi permette che siano somministrati in ospedale entro al massimo dieci giorni dal contagio con iniezione endovenosa a persone cosiddette fragili, perché con fattori di rischio che portano a prevedere un’evoluzione severa dei sintomi, per esempio individui obesi, affetti da diabete, cardiopatie, insufficienza renale, forme tumorali e over 65 anni…
Tuttavia, in base sia agli studi effettuati sia alla mia esperienza all’interno del day hospital per l’impiego degli anticorpi monoclonali da me coordinato all’ospedale universitario Federico II è evidente che più precoce è il loro impiego, cioè nei primissimi giorni del contagio che corrispondono alla fase virale caratterizzata da sintomi lievi (dura circa una settimana), più si contrasta la successiva fase infiammatoria, impedendo così al virus di premere una serie di “grilletti” che provocano un aggravamento dei sintomi con necessità di ospedalizzazione e ricoveri in terapia intensiva». La permanenza in ospedale per chi è stato trattato con gli anticorpi monoclonali antivirali è di circa un’ora, poi si può ritornare a casa e nei giorni successivi saranno effettuati controlli.
Sottolinea però l’infettivologo: «A fronte della dimostrata efficacia nel trattamento dei pazienti con Covid-19 lieve moderato e a rischio di progressione e in alcuni casi anche in malattia severa (in soggetti sieronegativi, cioè senza anticorpi anti-SARS-CoV-2) in Italia l’uso nella pratica clinica di tali farmaci è ancora scarso nonostante la loro disponibilità». Meriterebbero dunque maggiore considerazione anche per le loro ulteriori potenzialità, che potrebbero aprire nuove importanti strade nella lotta al contagio da percorrere a fianco del vaccino, arma principale contro il Covid ma che, con l’avvicendarsi delle varianti, sembra non essere sufficiente. «In termini di prevenzione del contagio i dati preliminari relativi all’impiego dei monoclonali con iniezione intramuscolare sono incoraggianti», prosegue Gentile. «Dagli studi si evince per il 77% dei casi una protezione immediata dopo la somministrazione per circa sei mesi. In America, dove ne è già stato autorizzato l’uso per i familiari di soggetti positivi al virus, si è visto che, se somministrati nell’arco delle 96 ore dal contatto, riducono di circa l’81% il rischio di infettarsi. Ritengo che questi farmaci racchiudano enormi potenzialità come arma complementare al vaccino per quanti, per problemi di immunodeficienza, non sviluppano anticorpi o per chi non può vaccinarsi, ma potrebbero anche essere utilizzabili in presenza di focolai, per esempio nelle scuole per bloccare la diffusione del contagio».
Antivirali in pillole: bene le sperimentazioni
 Altri farmaci che potrebbero dare una svolta positiva alla battaglia contro il Covid sono alcuni antivirali in pillole. «Due sono i più promettenti, che potrebbero cambiare la storia degli ultimi due anni, perché in grado di prevenire le forme gravi della malattia e dunque di ridurre i ricoveri ospedalieri», spiega l’infettivologo. «Di uno, sperimentato nel Regno Unito, si parla di un’efficacia preventiva pari al 30% circa, dell’altro made in Usa del 90%. Il loro principale punto di forza? Per assumerli non è necessario recarsi in ospedale e inoltre, se presi nei primissimi giorni del contagio, impedirebbero al virus di replicarsi, limitando i sintomi che diventerebbero simili a quelli di un’infezione respiratoria. Con un vantaggio enorme: poter convivere con un nemico decisamente meno temibile. Tutto questo, però, a patto di mettere a punto un’efficiente e veloce catena sanitaria che al tampone effettuato prima possibile in caso di sintomi sospetti e con risultato positivo faccia seguire l’immediata prescrizione dell’antivirale da parte del medico di famiglia e il recapito a domicilio da parte del farmacista. Sarebbe davvero il percorso più auspicabile per non vanificare una preziosissima opportunità terapeutica».
Altri farmaci che potrebbero dare una svolta positiva alla battaglia contro il Covid sono alcuni antivirali in pillole. «Due sono i più promettenti, che potrebbero cambiare la storia degli ultimi due anni, perché in grado di prevenire le forme gravi della malattia e dunque di ridurre i ricoveri ospedalieri», spiega l’infettivologo. «Di uno, sperimentato nel Regno Unito, si parla di un’efficacia preventiva pari al 30% circa, dell’altro made in Usa del 90%. Il loro principale punto di forza? Per assumerli non è necessario recarsi in ospedale e inoltre, se presi nei primissimi giorni del contagio, impedirebbero al virus di replicarsi, limitando i sintomi che diventerebbero simili a quelli di un’infezione respiratoria. Con un vantaggio enorme: poter convivere con un nemico decisamente meno temibile. Tutto questo, però, a patto di mettere a punto un’efficiente e veloce catena sanitaria che al tampone effettuato prima possibile in caso di sintomi sospetti e con risultato positivo faccia seguire l’immediata prescrizione dell’antivirale da parte del medico di famiglia e il recapito a domicilio da parte del farmacista. Sarebbe davvero il percorso più auspicabile per non vanificare una preziosissima opportunità terapeutica».
 Gentile segnala anche un recente studio italiano relativo all’aggiunta di L-Arginina, principio attivo da tempo conosciuto e di facile reperibilità e somministrato per via orale unito alla terapia standard dei pazienti ricoverati in unità sub-intensiva per Covid-19 grave. I primi dati della ricerca, condotta dall’Università Federico II di Napoli, dall’Ospedale Cotugno nel capoluogo campano e dall’Albert Einstein University di New York, hanno rilevato nei soggetti sottoposti a questo trattamento un decorso più favorevole con marcata riduzione dei giorni di ospedalizzazione e riduzione più precoce dell’assistenza respiratoria rispetto a chi era stato trattato con la sola terapia standard.
Gentile segnala anche un recente studio italiano relativo all’aggiunta di L-Arginina, principio attivo da tempo conosciuto e di facile reperibilità e somministrato per via orale unito alla terapia standard dei pazienti ricoverati in unità sub-intensiva per Covid-19 grave. I primi dati della ricerca, condotta dall’Università Federico II di Napoli, dall’Ospedale Cotugno nel capoluogo campano e dall’Albert Einstein University di New York, hanno rilevato nei soggetti sottoposti a questo trattamento un decorso più favorevole con marcata riduzione dei giorni di ospedalizzazione e riduzione più precoce dell’assistenza respiratoria rispetto a chi era stato trattato con la sola terapia standard.
Con la lattoferrina si recuperano gusto e olfatto
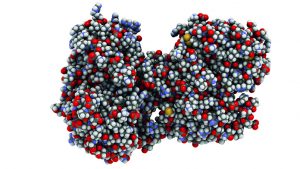 Nella battaglia contro il Covid, a fianco del vaccino stanno dunque dimostrando la loro validità, grazie alle ricerche sempre più approfondite, nuove munizioni terapeutiche. Ne fanno parte anche gli integratori a base di lattoferrina, di cui uno degli studi clinici più recenti condotti in collaborazione tra l’Università di Roma Tor Vergata, l’Università La Sapienza di Roma e SIMA conferma l’utilità nel trattamento dei pazienti con sintomi lievi da Covid-19 (raffreddore, dolori muscolo-scheletrici, alterazioni di gusto e olfatto o intestinali) o asintomatici.
Nella battaglia contro il Covid, a fianco del vaccino stanno dunque dimostrando la loro validità, grazie alle ricerche sempre più approfondite, nuove munizioni terapeutiche. Ne fanno parte anche gli integratori a base di lattoferrina, di cui uno degli studi clinici più recenti condotti in collaborazione tra l’Università di Roma Tor Vergata, l’Università La Sapienza di Roma e SIMA conferma l’utilità nel trattamento dei pazienti con sintomi lievi da Covid-19 (raffreddore, dolori muscolo-scheletrici, alterazioni di gusto e olfatto o intestinali) o asintomatici.
Spiega in proposito Elena Campione, professore associato dell’Unità Operativa di Dermatologia del Policlinico Universitario di Roma Tor Vergata e membro del Comitato Scientifico SIMA, che ha partecipato allo studio pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Enviromental Research and Public Health: «Nel nostro trial clinico sono stati studiati soggetti Covid-19 positivi asintomatici e con sintomi lievi, trattati con 1 grammo al giorno di lattoferrina per via orale in compresse e in formulazione spray intranasale. Gli effetti del trattamento sui sintomi Covid-19 sono stati osservati già dai primi giorni, con graduale scomparsa dell’alterazione o perdita del gusto e perdita dell’olfatto. Anche i sintomi intestinali sono migliorati insieme ai dolori muscolari. Non sono stati rilevati eventi avversi dal trattamento».
Inoltre, nei soggetti trattati con lattoferrina si è osservato un periodo pari a 14 giorni per ottenere la negativizzazione del tampone molecolare, rispetto ai 27 giorni dei soggetti trattati con terapia standard e 32 del gruppo non trattato. «La lattoferrina è una glicoproteina presente in tutti i fluidi corporei e nelle mucose, rilasciata dai nostri globuli bianchi (neutrofili) come componente fondamentale della cosiddetta immunità innata, cioè naturale», precida Campione. «Inibisce direttamente l’infezione legandosi ai siti dei recettori virali e alle cellule dell’ospite impedendo che il virus le infetti. Si lega anche all’ormai famigerata proteina Spike del coronavirus. Inoltre, aumenta la risposta immunitaria all’invasione virale e ha funzioni antinfiammatorie indirette potendo legare anche il ferro libero che invece favorisce la replicazione del virus. Riguardo al meccanismo d’azione della lattoferrina nell’impedire la replicazione virale e l’invasione della cellula ospite e sul processo biochimico che sottende la funzione antivirale sono in corso ulteriori studi». Sull’impiego di integratori di lattoferrina, l’esperta avverte di evitare sempre il fai-da-te, chiedendo consiglio al proprio medico e verificando che l’integratore sia a base di lattoferrina pura, ovvero desaturata.
Il monitoraggio dell’aria indoor
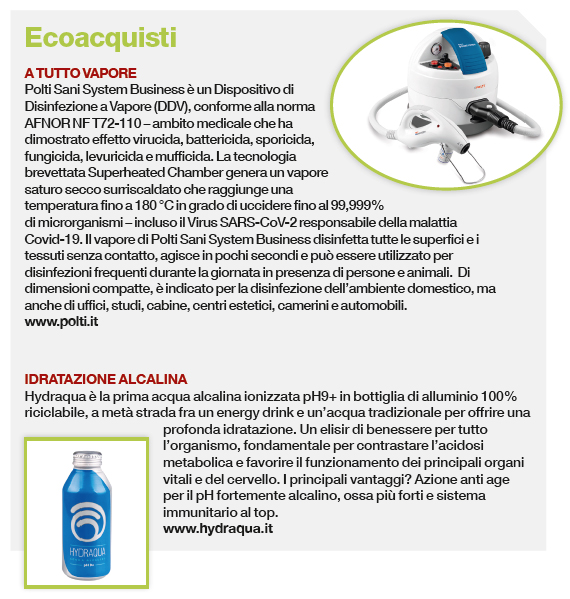 Sul fronte prevenzione per ridurre il più possibile il rischio di contrarre il Covid-19 giocano un ruolo decisivo anche altri fattori come il monitoraggio della qualità dell’aria, cioè la valutazione della maggiore o minore presenza di anidride carbonica (CO2) negli ambienti al chiuso dove, peraltro, in questa stagione trascorriamo la maggior parte del tempo: abitazioni, aule scolastiche, uffici palestre, ristoranti e via di seguito. Spiega Gianluigi De Gennaro professore di chimica dell’ambiente all’Università di Bari e membro del Comitato Scientifico SIMA: «Il livello di CO2 aumenta in base al numero di persone presenti in un locale. Dunque un suo valore elevato segnala un rischio maggiore di respirare aria espirata da altri con droplet eventualmente infetti e la necessità di areare, aprendo le finestre, per allontanare e disperdere eventuali particelle virali che, essendo molto piccole (inferiori a 1 micron), potrebbero altrimenti permanere nell’ambiente continuando a galleggiare nell’aria anche per diverse ore.
Sul fronte prevenzione per ridurre il più possibile il rischio di contrarre il Covid-19 giocano un ruolo decisivo anche altri fattori come il monitoraggio della qualità dell’aria, cioè la valutazione della maggiore o minore presenza di anidride carbonica (CO2) negli ambienti al chiuso dove, peraltro, in questa stagione trascorriamo la maggior parte del tempo: abitazioni, aule scolastiche, uffici palestre, ristoranti e via di seguito. Spiega Gianluigi De Gennaro professore di chimica dell’ambiente all’Università di Bari e membro del Comitato Scientifico SIMA: «Il livello di CO2 aumenta in base al numero di persone presenti in un locale. Dunque un suo valore elevato segnala un rischio maggiore di respirare aria espirata da altri con droplet eventualmente infetti e la necessità di areare, aprendo le finestre, per allontanare e disperdere eventuali particelle virali che, essendo molto piccole (inferiori a 1 micron), potrebbero altrimenti permanere nell’ambiente continuando a galleggiare nell’aria anche per diverse ore.
 Molti studi dimostrano che la trasmissione aerea del virus in ambienti chiusi è una pericolosa via di contagio e questo avviene non solo attraverso colpi di tosse o starnuti, ma anche solo respirando e parlando, basti pensare che uno starnuto libera nell’aria fino a 2 milioni di goccioline, un colpo di tosse all’incirca 1 milione e il solo parlare a voce alta quasi 3.000. Da qui l’importanza di misurare mediante specifici dispositivi la quantità di CO2 all’interno di una stanza che non dovrebbe superare i 700 ppm (parti per milione), livello ritenuto sicuro e in cui il rischio di respirare aria espirata da altri presenti nello stesso ambiente è molto inferiore all’1%».
Molti studi dimostrano che la trasmissione aerea del virus in ambienti chiusi è una pericolosa via di contagio e questo avviene non solo attraverso colpi di tosse o starnuti, ma anche solo respirando e parlando, basti pensare che uno starnuto libera nell’aria fino a 2 milioni di goccioline, un colpo di tosse all’incirca 1 milione e il solo parlare a voce alta quasi 3.000. Da qui l’importanza di misurare mediante specifici dispositivi la quantità di CO2 all’interno di una stanza che non dovrebbe superare i 700 ppm (parti per milione), livello ritenuto sicuro e in cui il rischio di respirare aria espirata da altri presenti nello stesso ambiente è molto inferiore all’1%».
Come orientarsi tra i molti dispositivi ormai disponibili nei negozi di sanitari, di elettrodomestici o in vendita online? «Quelli che consentono misure accurate hanno tecnologia NDIR – questa dicitura è riportata in etichetta – e bisogna accertarsi che risultino calibrati», risponde De Gennaro. «Di piccole dimensioni, pari circa a quelle di uno smartphone, spesso segnalano con un colore quando si è superato il livello di guardia di CO2 oppure riportano un numero che appunto non deve superare i 700 ppm. Per una prevenzione davvero efficace andrebbero posizionati negli ambienti indoor più frequentati, e tenuti sempre accesi per sapere quando è opportuno ventilare il locale e per quanto tempo».
Strumentazioni hi-tech per studiare come si comporta il virus
Innovative prospettive per alzare le difese contro il virus promettono inoltre gli esperimenti svolti nel laboratorio di biosicurezza BSL3 dell’Ospedale San Polo di Monfalcone (Gorizia) attraverso strumentazioni di sofisticata tecnologia, tra cui uno speciale aerosolizzatore importato dagli Usa grazie al sostegno di SIMA e alla sponsorizzazione della Fondazione Kathleen Foreman Casali. Si tratta di uno strumento unico in Italia che permette di raccogliere il virus Covid-19 senza alterarlo e di studiare in quali condizioni si replica nell’aria, in quali quantità esplica l’infettività e per quanto tempo.
Racconta Pierluigi Barbieri, docente presso il dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche dell’Università di Trieste che coordina un team di operatori sanitari con competenze diverse tra cui medici, biologi, chimici, specialisti di aerosol, infermieri che hanno unito forze e professionalità nella ricerca: «L’obiettivo è verificare gli aspetti ambientali collegati al virus, a oggi ancora scarsamente studiati, e che influiscono sulla sua permanenza nell’aria e sul grado e sulla durata della sua infettività, come per esempio l’inquinamento e in particolare i livelli di particolato atmosferico, o l’umidità, per arrivare a testare l’efficacia di materiali filtranti e impianti di trattamento dell’aria oppure mascherine già esistenti, ma anche mettere a punto nuovi dispositivi mirati contro la diffusione del virus: per esempio strumentazioni per la purificazione dell’aria e mascherine in grado di bloccare il passaggio anche delle particelle più piccole e capaci di proteggere dalle varianti più attuali di Covid-19.
Obiettivo quest’ultimo di estrema importanza, visto che uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Trieste da me coordinati e di ASUGI, con la supervisione del professor Maurizio Ruscio (direttore della SC Laboratorio Analisi) e con esperimenti svolti nel laboratorio di biosicurezza BSL3 dell’Ospedale San Polo di Monfalcone, ha dimostrato come goccioline di dimensioni inferiori a 5 micrometri – che le attuali mascherine chirurgiche non riescono a fermare – siano in grado di veicolare il virus SARS-CoV-2 che mantiene la capacità di replicarsi e infettare. La capacità si perde quando il virus nell’aerosol è poco, quindi – in situazioni reali – a distanza da pazienti infetti o quando la carica virale è bassa (i.e. inferiore a 104 PFU/mL nel liquido areosolizzato).
Da qui l’importanza di mantenere il distanziamento anche all’aperto e se si indossa la mascherina. Le nostre ricerche sono in continua evoluzione e stiamo per testare cellule ingegnerizzate, più sensibili rispetto a quelle usate finora e più simili a quelle del naso umano e del sistema respiratorio umano, per affinare gli studi sulle modalità di replicazione del virus. Gli sviluppi della ricerca del gruppo multidisciplinare ora sono focalizzati sulla rilevazione dell’infettività presente nell’aria in ambienti in cui si trovano pazienti infetti e risultati preliminari mostrano, fortunatamente, assenza di virus infettivo nell’aria dei reparti di geriatria e infettivologia delle strutture sanitarie finora indagate».




