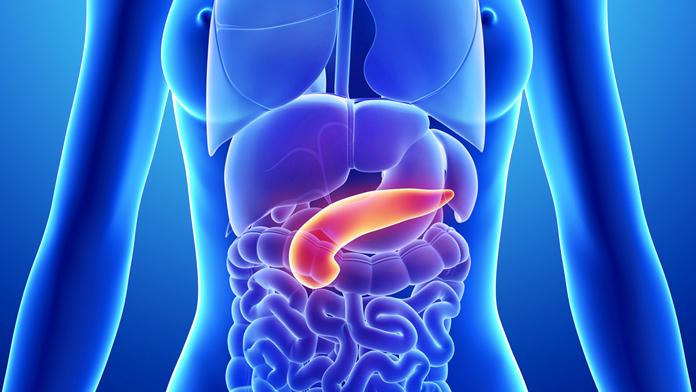Tre anni fa Kate Granger, medico britannico, scoprì di essere affetta da una raro e aggressivo tumore. Oggi, ripercorrendo il momento della diagnosi, riaffiora ancora una delusione: il medico che pronunciò la parola “cancro” non si presentò neppure, né la guardò negli occhi. Per quel medico e per tutti quelli dopo, lungo il difficile percorso terapeutico, che l’avevano fatta sentire «solo un corpo malato e non una persona reale», come ha raccontato recentemente alla BBC Radio 4, ha dato il via all’iniziativa #hellomynameis su Twitter per rispolverare il contatto umano tra medici e pazienti. Con gesti semplici, come una stretta di mano e dire il proprio nome (da qui il ‘Buongiorno, il mio nome è…’, slogan della campagna). Quella che ora è diventata una campagna di proporzioni nazionali, con un finanziamento governativo di 40 mila sterline, l’adesione di oltre 400 mila operatori sanitari e celebri testimonial dal Primo Ministro britannico David Cameron all’attrice Drew Barrymore e al cantante Bob Geldof, riaccende la luce su un tema sempre attuale: l’importanza del rapporto medico-paziente. In un’oncologia dove le terapie sono personalizzate, con tecniche e farmaci molecolari che sono entrati capillarmente nella pratica clinica, anche la relazione umana dovrebbe essere misurata sul singolo, a tutto vantaggio del percorso di cura e assistenza. Ma ancora non è così. Ne parliamo con Laura Gangeri, pedagogista della Psicologia clinica dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano (Int), che si occupa di formazione di medici e operatori.
Presentarsi e guardare il paziente negli occhi: basterebbe solo questo per umanizzare il rapporto medico-paziente?
Può essere sicuramente una strategia piacevole ed efficace per rompere il ghiaccio e iniziare una relazione, avvicinandola molto al tipo di rapporti che si vivono fuori dall’ambito ospedaliero e lontani dalla malattia. Ovviamente non basta per costruire un rapporto più profondo di fiducia, dove sia il medico che il paziente devono avere un ruolo da protagonisti.
Un rapporto alla pari, quindi, sarebbe l’ideale?
No, la relazione medico-paziente non può mai essere alla pari. E’ lo stesso paziente a desiderare che il suo medico sia in una posizione superiore, per competenze tecniche, esperienza e capacità di gestione di un rapporto complesso. Il paziente ha bisogno di essere accolto e che il medico non neghi il carico emotivo legato all’esperienza di malattia.
Perché esistono ancora delle difficoltà per garantire questo tipo di ‘accoglienza’?
Molti operatori denunciano la scarsità di tempo per instaurare una relazione ottimale, un punto cruciale su cui dovrebbe porre l’attenzione l’intero sistema sanitario. Importante è anche la capacità del medico di ascoltare: questa si impara con specifiche tecniche, ascoltare un paziente non significa farsi carico della sua emotività bensì accoglierla per facilitare la cura e l’assistenza. Le linee guida dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) sottolineano il valore di una formazione affinché i medici imparino a gestire il rapporto con i pazienti ma nelle università non esiste questa realtà. E’ un vuoto culturale che dovrebbe essere colmato. Con riscontro positivo anche sulla pratica clinica, per costruire un progetto di cura sul singolo paziente, più vicino alle sue esigenze e aspettative.
Anche i pazienti possono contribuire a migliorare il rapporto con il medico?
Oggi diamo attenzione alla ‘patient education’, l’educazione del paziente e della famiglia a ciò che gli sta accadendo per essere attivo nella situazione di difficoltà, prendersi la responsabilità dei suoi bisogni e scegliere insieme al medico, non da solo o, all’opposto, delegare al medico. Per incoraggiarli al dialogo, sono stati costruiti degli elenchi con possibili domande che vengono consegnate ai pazienti durante le prime visite, dei suggerimenti per ottenere informazioni utili su malattia, esami, terapie o sperimentazioni cliniche.
Quanto conta il rapporto di fiducia sulle terapie?
Molto. Il comitato etico dell’Int, insieme a noi psicologi, ha avviato uno studio per valutare se le informazioni contenute nel consenso informato di una sperimentazione clinica sono sufficienti al paziente per decidere consapevolmente se partecipare allo studio oppure no. Dai dati, di prossima pubblicazione, emerge che la relazione con il medico ha un peso enorme su una scelta così importante: la maggior parte dei pazienti sceglie sulla fiducia riposta nel medico piuttosto che sulla base delle chiare informazioni fornite.
Cinzia Pozzi